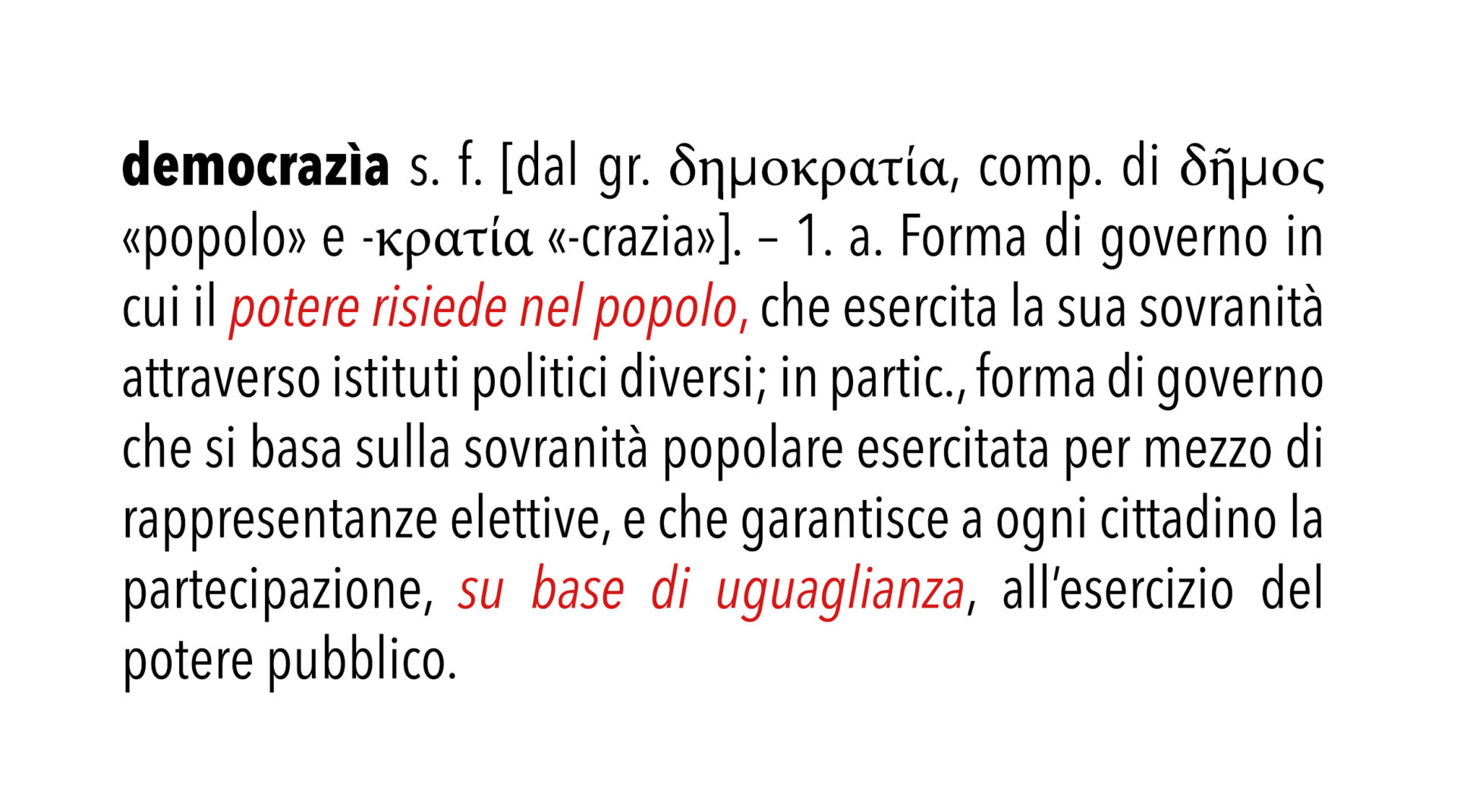
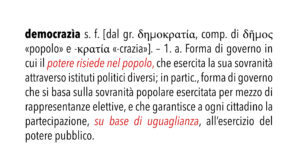 di Gabriele Sarti
di Gabriele Sarti
Il voto è la fonte nominale del potere politico, mentre il denaro ne è la fonte reale. Il sistema capitalistico è democratico nella forma, ma plutocratico nella sostanza. Al di la della retorica con cui molto spesso si definisce la democrazia, occorre fare uno sforzo, oggi, per valutare come taluni sviluppi della tecnologia possano avere introdotto fattori tali da modificare il funzionamento della stessa.
Qualcuno ha recentemente sostenuto che i social hanno sdoganato l’imbecillità. Forse l’opinione è un po’ estrema, ma non del tutto errata. Ma prendiamo un esempio meno estremo. Uno vale uno secondo la filosofia di un movimento politico che pretende oggi di fare scuola di democrazia. È questo un concetto democratico? Apparentemente sì, ma di fatto potrebbe trattarsi di un concetto con risultati assolutamente negativi. Senza tirare in ballo Platone e la sua tesi del governo dei saggi, è constatazione banale quella secondo cui se undici imbecilli valgono elettoralmente più di dieci premi Nobel c’è qualcosa che non quadra. E non sul piano formale, ma nella sostanza, negli effetti, nel risultato.
La conclusione non può che essere una sola: la democrazia non può essere racchiusa solo nell’espressione del voto, anche quando questo sia il più universale possibile. Il voto, quando non sia solamente un rito formale è, da un lato, il giudizio a consuntivo su chi ha esercitato il potere e il governo per un certo lasso di tempo. Ed è, anche, il momento in cui avviene l’espressione di una indicazione programmatica per il futuro. Indica le esigenze, i bisogni e le speranze dei cittadini elettori. Ed è questa la fase più importante dell’espressione della democrazia. Quando il cittadino è chiamato a esprimere i suoi bisogni, a fare conoscere i limiti negativi del suo stato sociale del momento e le sue esigenze di vita e di sviluppo. E per conseguire i suoi desiderata delega la gestione della cosa pubblica ad altri cittadini di cui ha fiducia.
Questa espressione di volontà e di speranza deve avvenire prima del voto; quando si definiscono i programmi per il futuro, deve avvenire in un contesto di dialettico confronto con l’insieme della cittadinanza, con chi ha governato e chi si propone sia come continuità di programmi, sia come alternativa di proposte. Naturalmente ciò presuppone che ci sia democrazia anche nella vita cittadina a tutti i livelli, nei luoghi di lavoro, nel mondo della scuola, etc.
Qualcuno dirà: questa è solo utopia. No, non è così. Ogni tanto non sarebbe male rivolgere uno sguardo alle nostre spalle. Certo non troppo indietro, ma abbastanza; ed è giusto, per chi ha vissuto questi tempi, farne menzione perché molti non possono, per età, avere memoria storica di essi. Sto parlando di Bologna degli anni dal ‘55 grosso modo al ‘70/75. È già stato segnalato in un precedente articolo su Resistenza (il primo numero della nuova serie), come in quegli anni si fosse determinata una condizione diffusa di vera autentica, organica ed efficace democrazia. Si perdonerà, spero, la ripetizione.
Centinaia di consiglieri comunali e di quartiere, centinaia di membri di consigli di amministrazione di cooperative di tutti settori, centinaia di piccoli e medi imprenditori e artigiani, centinaia di commercianti, decine di amministratori di aziende pubbliche (municipalizzate), centinaia di sindacalisti, alcune migliaia di contadini e di braccianti, ogni mattina, dopo il caffè, cominciavano a interrogarsi su come migliorare il modo d’essere della loro specifica funzione e situazione, del loro ambiente, della loro realtà locale. Questa massa di produzione intellettuale trovava poi momento di confronto e di sintesi nelle centinaia di riunioni (quasi sempre serali) che l’insieme delle varie forme di aggregazione politica, sindacale, professionale e cooperativa tenevano nel corso di ogni settimana.
La sintesi ultima di tutto questo lavoro di meningi erano i partiti bolognesi (pressoché tutti), i sindacati, le aziende. È questa realtà che spiega la differenza della nostra situazione (in larga parte tipica di tutta l’Emilia) e gli effetti della stessa sulla condizione economica e sociale della nostra area. L’elaborazione politica non era tanto o solo un qualcosa calato magnanimamente dall’alto da parte di una classe dirigente di intellettuali e tecnici di alto livello culturale, tecnico e (perché no?) morale, quale era quella bolognese di allora. Era il frutto certo della capacità di quella classe dirigente di portare a sintesi programmatica il prodotto di un processo democratico estremamente diffuso, che non aveva assolutamente riscontro precedente e contemporaneo in nessun altro paese europeo e che purtroppo non ha oggi nessun esempio.
La domanda a questo punto non può che essere: è possibile, è pensabile ricreare una simile condizione o qualcosa che a essa si avvicini? Risposta non agevole. Una cosa però va detta. Ciò che qui viene ricordato della Bologna di quei tempi, altro non era che l’applicazione, certo con spirito bolognese, del dettato costituzionale. Questo punto di riferimento, la Costituzione, resta tuttora quale faro della vita democratica del nostro paese. L’Anpi ce lo ricorda ogni giorno con la sua vita e la sua attività.

